Yomanim - DIARI - יומנים
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Categoria: DIARI
- Visite: 4560
SUKKOT IN GUERRA A TEL AVIV
di Giuseppe Kalowski, Tel Aviv, 19 ottobre 2024
Sukkot, che stiamo celebrando questa settimana, o Festa delle Capanne, è una delle tre festività ebraiche che comportavano il pellegrinaggio a Gerusalemme come a Pesach e a Shavuot.
Ha anche un significato agricolo, di ringraziamento ad Hashem per l'abbondanza del raccolto; ma simboleggia anche la molteplicità dell'intero popolo ebraico che mai come quest'anno rende attualissimo l'antichissimo significato di Sukkot.
Il Lulav (palma), l'Etrog (cedro), l'Aravà (salice) e il Hadas (mirto) simboleggiano l'unità della natura con il popolo ebraico pur nella sua diversità e molteplicità.
Ma Sukkot innanzitutto commemora i 40 anni di peregrinazione nel deserto dopo l'uscita dall'Egitto, punizione divina comminata agli ebrei perché si realizzasse così un ricambio generazionale e nascesse in loro un sentimento di dipendenza e comunione con Hashem.
Questo periodo ha avuto anche la funzione di trasformare il popolo, rendendolo una comunità, un'entità coesa e stabile.
In questi 40 anni gli ebrei vissero in Capanne protette solo da Hashem. Perciò costruire oggi Capanne, simboleggia pienamente la protezione divina anche in condizioni come quella in cui si trova in questo tragico periodo il popolo d'Israele.
È di queste ore la notizia dell'eliminazione di Sinwar, capo di Hamas e ideatore del genocidio antisemita in Israele il 7 ottobre 2023.
Mai come quest'anno la Sukkah (Capanna) richiama la fragilità dell'esistenza umana: mai come quest'anno il popolo d'Israele ha temuto, e ancora teme, per la propria continuità e per la propria esistenza…
In un attimo tutto è diventato in apparenza illusorio; paradossalmente questa situazione ci deve incoraggiare a essere più umili e più uniti, apprezzando le conquiste sociali e culturali del piccolo stato ebraico.
La Palma, il Cedro, il Salice e il Mirto simboleggiano tutti gli ebrei con i loro dubbi e diversità ma con la comune aspirazione al benessere interiore, condizione che oggi più di ieri deve stimolare una condivisione quale fondamento identitario della società israeliana
C'è anche una presenza profetica in questa festività, un tratto che oggi sembra irrealizzabile vista la situazione in cui non solo Israele, ma tutti gli ebrei si trovano: tutte le nazioni del mondo celebreranno insieme questa festa come segno di pace e di unità.
È nostra prerogativa, anche dopo un anno di guerra terribile, invitare tutti a una riflessione sulla relazione tra l'uomo e l'aspetto divino.
Sukkot è un invito all'unità e alla fiducia nella presenza divina, esattamente come nei 40 anni di peregrinazione nel deserto.
Sukkot deve stimolare e ricordare a tutti noi, ma soprattutto ai nostri troppi nemici, i valori fondamentali dell'esistenza e della coesistenza umana.
L'anno che abbiamo passato ci ha lasciato una sensazione di precarietà, la stessa sensazione trasmessa da una costruzione fragile e temporanea come la Sukkah.
Per celebrare l'abbondanza dei raccolti nei campi e l'opportunità che Hashem ci ha dato di andare in Israele la Torà ci comanda di gioire ed esultare: durante questa festività gli ebrei nell'antichità offrivano sacrifici come espiazione per tutti i popoli e si pregava per la pace universale.
Noi non dobbiamo dimenticare questo precetto soprattutto adesso, quando la pace sembra impossibile; Sukkot ci impone di trasformare l'umanità per ottenere la pace per tutto il genere umano, a dispetto dell'antisemitismo dilagante nella parte politica cosiddetta democratica e progressista, nel mondo occidentale, da parte di quella fetta di società teoricamente più avanzata - che ci fa pensare che la storia non cambia al di là delle apparenze.
Sostenere oggi un concetto così alto può sembrare un atteggiamento irrealistico e illusorio, invece è un’aspirazione dalla quale noi non possiamo e non dobbiamo mai separarci.
HAG SUKKOT SAMEACH
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Categoria: DIARI
- Visite: 6805

7 OTTOBRE: SENZA ALTERNATIVA
di Giuseppe Kalowski, Tel Aviv, 6 ottobre 2024
Dal terribile giorno del massacro del 7 ottobre 2023 Israele ha ancora 101persone in ostaggio a Gaza, ha seppellito centinaia di soldati e civili e circa 70.000 cittadini residenti al nord si sono dovuti spostare più a sud per evitare i razzi di Hezbollah.
L'incredibile resilienza di Israele e del popolo ebraico in generale ha comunque un limite: come ho già scritto nel mio precedente articolo del 18 settembre scorso ("Un anniversario di guerra") Israele non può permettere una interminabile guerra di attrito con Hezbollah; l'eliminazione del capo di Hezbollah, Nasrallah, e l'invasione del nord del Libano da parte dell'Idf segnano l'inizio di una nuova delicatissima fase: per chi ancora non l'ha capito, a Israele, dopo lo scempio del 7 ottobre, non basta più un "cessate il fuoco" o una tregua temporanea. La popolazione, e noi tutti, chiediamo una soluzione definitiva ai continui attacchi da nord e da sud. Lo scontato sconfinamento di Israele in Libano è l'unica via per ottenere sicurezza per la popolazione israeliana: mentre scrivo, arrivano razzi in continuazione sempre più in profondità nel territorio ebraico.
Chi crede che sia possibile un accordo senza un intervento militare è uno sprovveduto o è in malafede. Per poter arrivare a un "cessate il fuoco", Hezbollah deve essere cacciato fino al fiume Litani con la forza, in modo che possa essere finalmente applicata la risoluzione 1701 del 2006 fino ad oggi mai di fatto adottata.
Hezbollah non può essere eliminato ma può essere ridimensionato tramite una sconfitta militare che verrebbe vista di buonissimo occhio dai libanesi di fede diversa; l'obiettivo deve essere un nuovo equilibrio politico all'interno del Libano che dia maggiore forza alle altre componenti religiose del paese dei cedri. Con la morte di Nasrallah il movimento sciita si è indebolito e gli USA credono che ci sia l'opportunità di poter eleggere un nuovo presidente, che manca da due anni, non succube di Hezbollah.
Se tutto questo avverrà, potrà esserci un nuovo futuro nei rapporti tra Israele e il Libano, e il giorno in cui Hezbollah verrà eliminato ci saranno i presupposti per un trattato di pace tra i due stati.
La "campagna di terra" di Israele in Libano, concepita come ho scritto, è la testimonianza tangibile che il 7 ottobre è presente nella coscienza di tutti, una commemorazione sul campo, perché esprime un segnale inequivocabile: " Stiamo combattendo affinché non possa accadere mai più".
Un "mai più" già evocato, ma evidentemente non sufficiente per allertare la nostra memoria che ci ha fatto cadere nuovamente nella trappola.
L'apatia e l'indifferenza del mondo e delle istituzioni internazionali da quasi un anno non hanno lasciato alternative a Israele : l'invasione del Libano ha l'appoggio totale della popolazione israeliana e della classe politica, in contrasto alla cronaca degli ostaggi che sta dividendo e lacerando la società israeliana.
Hamas, di là dalle chiacchiere, e per stessa ammissione della amministrazione americana, non è interessato a un accordo con Israele per la liberazione degli ostaggi. Sinwar ha capito che l'unica speranza di sopravvivenza sua e di Hamas è l'allargamento del conflitto; solo così può sperare in un allentamento della pressione militare israeliana a Gaza. Ma forse le cose non procedono come Sinwar sperava, visto il fallimento dell'attacco missilistico iraniano del 1 ottobre e l'andamento della guerra in Libano. Il destino degli ostaggi è in mano, purtroppo, a questo folle calcolo.
Il 7 ottobre 2023 deve insegnarci un concetto fondamentale: non dobbiamo avere paura, ma dobbiamo essere consapevoli di combattere per una causa giusta, rimanere uniti senza cadere nella stucchevole polemica politica che la rende ancora più odiosa quando si è nel mezzo di una guerra di sopravvivenza.
Noi tutti ci auguriamo un ritorno a casa degli ostaggi e un nuovo anno di pace: ma si è capito che la pace ce la dovremo conquistare da soli senza farci troppe illusioni.
SHANA TOVA!
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Categoria: DIARI
- Visite: 4672

ROSH HODESH ELUL 5784...LO SHOFAR CI UNISCA
In quest'anno terrificante siamo arrivati al momento in cui ci prepariamo attoniti, sgomenti e arrabbiati alle scuse (Selichot) per i nostri comportamenti, per ricevere il perdono.
Tra un mese entreremo nel nuovo anno e quello che ci sta per lasciare è stato testimone di grande sofferenza per il popolo d'Israele.
Gerusalemme rispetto a Tel Aviv sembra più tranquilla, più equilibrata, più riflessiva e più consapevole del periodo che noi tutti stiamo vivendo: la consapevolezza interiore di chi è sicuro che ce la faremo, che supereremo anche questa…
Nella capitale d'Israele si respira un'unità d’intenti che Tel Aviv sembra avere smarrito a causa degli ultimi terribili avvenimenti.
Ognuno ha la dignità di esprimere il proprio pensiero ma sicuramente si sta eccedendo nel linguaggio e nei comportamenti e l'attuale classe politica non è da meno.
ELUL è un'occasione, un'opportunità per cercare e ritrovare l'unione e la coesione che sembra persa.
Al Kotel (muro del pianto) in questo mese che è cominciato il 3 settembre, non vanno per pregare solo i religiosi ma anche centinaia di migliaia di persone non religiose che sentono il bisogno di un avvicinamento interiore all'ebraismo.
ELUL è la scintilla che dà l’avvio al percorso di avvicinamento del perdono che Hashem concederà di fronte a un sincero ravvedimento.
Lo Shofar può rivelarsi uno strumento efficace nel tentativo di ricompattare il popolo d'Israele: i suoni emessi rappresentano unità e pacificazione, uguali per tutti, senza alcuna distinzione.
È un richiamo ad ascoltare la voce eterna e lì non può esserci divisione, competizione, vittoria o sconfitta.
Il mese di ELUL, con lo Shofar che lo rappresenta, deve farci prendere coscienza che un conflitto interno causerà una sconfitta per tutti noi, rischiando la disgregazione dello Stato ebraico.
L'auspicio e la speranza sono che un evento così importante faccia riflettere tutti noi affinché venga privilegiato il bene comune e non solo quello personale.
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Categoria: DIARI
- Visite: 861

UN ANNIVERSARIO DI GUERRA di Giuseppe Kalowski, Roma,
18 settembre 2024
Si avvicina repentinamente la possibilità della resa dei conti con il Libano di Hezbollah. Israele sta perdendo di fatto la sua sovranità nel nord: i continui attacchi con missili e droni che hanno costretto gli oltre sessantamila abitanti Israeliani a lasciare le proprie case da quasi un anno, stanno per provocare un inevitabile allargamento del conflitto.
Qualche giorno fa un missile balistico lanciato dagli Houti dello Yemen, direzione aeroporto di Tel Aviv, è stato intercettato solo quando era entrato nel territorio israeliano e non prima dai paesi alleati: questo è un segnale allarmante perché sia gli USA che la Giordania non sono intervenuti.
L'audacia e la sfrontatezza degli Houti uniti alla loro capacità di produrre droni e missili a lunga gittata grazie all' Iran stanno per provocare una escalation senza probabilmente coinvolgere quest'ultimo che non vuole rischiare una brutale rappresaglia da parte d'Israele e che comunque aspetta il risultato delle elezioni americane sperando nella vittoria di Kamala Harris.
L'Iran e i suoi alleati hanno creato ad arte questa situazione suscitando un profondo allarme nella società israeliana per spingere il governo Netanyahu e scendere a patti con i terroristi di Hamas.
Ma questa dinamica si sta rovesciando: più aumenta purtroppo la sfiducia nella possibilità di salvare gli ostaggi più si evidenzia la necessità di risolvere militarmente la questione in modo risolutivo e definitivo con Hezbollah passando all'offensiva.
È in questa ottica che si deve decifrare la scelta decisionistica di Netanyahu : la volontà di sbarazzarsi del ministro della difesa Gallant con il quale è in polemica da più di un anno con Gideon Saar, ex dissidente del Likud, a capo di un piccolo partito di opposizione e fino a pochi mesi fa federato con il partito di Benny Gantz, soddisfa la necessità di una maggiore coesione all'interno del gabinetto di guerra visto che Saar ha sempre dichiarato che l'accordo con Hamas rappresenterebbe una resa a Sinwar, ma eviterebbe anche la possibilità della formazione di un governo di unità nazionale caldeggiato fortemente dal presidente Herzog.
Ma al di là di queste facili deduzioni c'è un altro fattore, forse determinante, che spinge Israele verso un'opzione militare ampia in Libano : la data del 25 Agosto scorso.
Quel giorno l'aviazione con un attacco preventivo e simultaneo di oltre cento aerei ha quasi totalmente distrutto i missili e i droni che avrebbero dovuto colpire Israele come vendetta per l'uccisione del capo militare di Hezbollah.
Il 25 Agosto ha fotografo forse una nuova realtà a Israele : forse, in caso di guerra, il prezzo da pagare in vite umane è molto più basso di quello stimato in precedenza.
Non colpire nelle prossime settimane, in prossimità dell'inverno, condannerebbe sessantamila israeliani a un altro anno di esilio dalle proprie case.
È di eri pomeriggio 17 Settembre la clamorosa esplosione contemporanea dei cercapersone in dotazione ai terroristi di Hezbollah per evitare di farsi individuare con i cellulari. Il bilancio, pesante, è di migliaia di feriti e di almeno una ventina di morti; è da notare però che l'incredibile avvenimento non è stato rivendicato da Israele e che è stato accolto con festeggiamenti dai ribelli siriani..
Questo avvenimento come interpretarlo? Può significare una volontà di affrettare l'operazione militare su larga scala o provare a dissuadere Hezbollah per cercare di arrivare a un accordo?
Sinwar a Gaza continua con la politica dell'assassinio e dei video: questa macabra e criminale dinamica alimenta la spaccatura della società israeliana, cavalca abilmente la tragedia dei familiari dei rapiti, strumentalizzati dall'opposizione politica. Siamo quasi a un anno dal maledetto 7 ottobre 2023 e ci accingiamo ad accogliere il nuovo anno ebraico e le altre festività con gioia e alla ricerca del perdono, ognuno nel suo più profondo intimo ; ma anche con tristezza e con la consapevolezza del drammatico momento che noi tutti stiamo vivendo.
Ci sentiamo tutti in pericolo anche se il mondo circostante non lo capisce o fa finta di non capirlo;io credo però che siamo quasi arrivati all'atto conclusivo di questo orrore che Israele e noi ebrei abbiamo dovuto subire, ma che una volta ancora ce la faremo.
Am Israel Hai!!
- Dettagli
- Scritto da Barbara de Munari
- Categoria: DIARI
- Visite: 2921
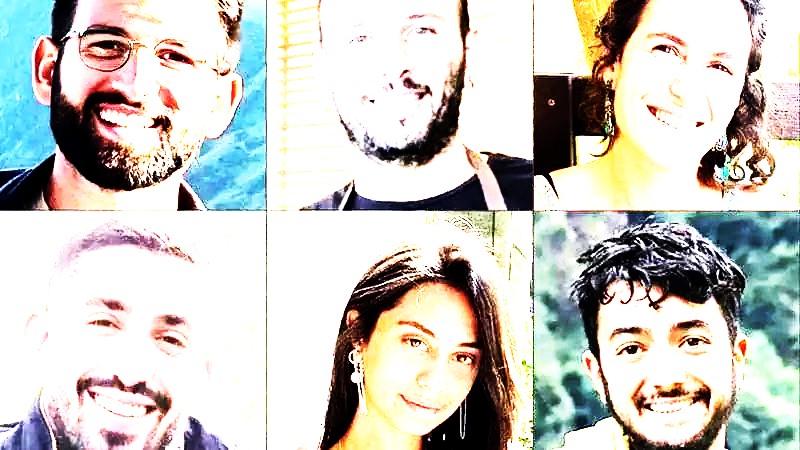
ALBA MORTALE di Giuseppe Kalowski,
Tel Aviv,
1 settembre 2024
Triste, tristissimo risveglio qui in Israele, per noi tutti.
Forse meno per quelli che da quasi un anno non hanno fatto "una piega" di fronte allo scempio del 7 ottobre e al rapimento di 250 persone di 30 nazionalità diverse. L'Onu e la Croce Rossa sono la vergogna dei nostri tempi.
Ieri sera era già stato comunicato il ritrovamento di alcuni corpi senza vita ed io, probabilmente inconsciamente, mi sono svegliato tardi questa mattina, come se volessi evitare l'inevitabile notizia, come se non volessi scoprire la penosa realtà....
Israele è sotto shock, incredula: si teme un'ulteriore spaccatura tra chi vuole un accordo a qualsiasi costo, pur di salvare coloro che si spera siano ancora in vita, e gli altri, che invece non vogliono cedere di fronte a condizioni ritenute inaccettabili.
In questa situazione, la notizia dell'uccisione di tre poliziotti israeliani in Cisgiordania, vittime di un agguato mentre erano in macchina, è passata in sordina.
Hamas purtroppo "gioca" in modo molto abile su questa divisione: nonostante sia sull'orlo della catastrofe, riesce con un cinismo incredibile a penetrare le corde emotive della società israeliana.
Si prevedono nelle prossime ore grandi manifestazioni contro l'attuale governo, che a loro volta saranno usate dai media occidentali per cercare di dimostrare l'inadeguatezza di Netanyahu.
Non so quale possa essere la scelta giusta, ma serve una svolta, una decisione coraggiosa.
Quale?
Non lo so.
Ma condivido le parole di Netanyahu, parole con le quali ha concluso il suo breve discorso poco fa in tv:
«Chi uccide gli ostaggi non vuole un accordo»...
Pagina 3 di 7

