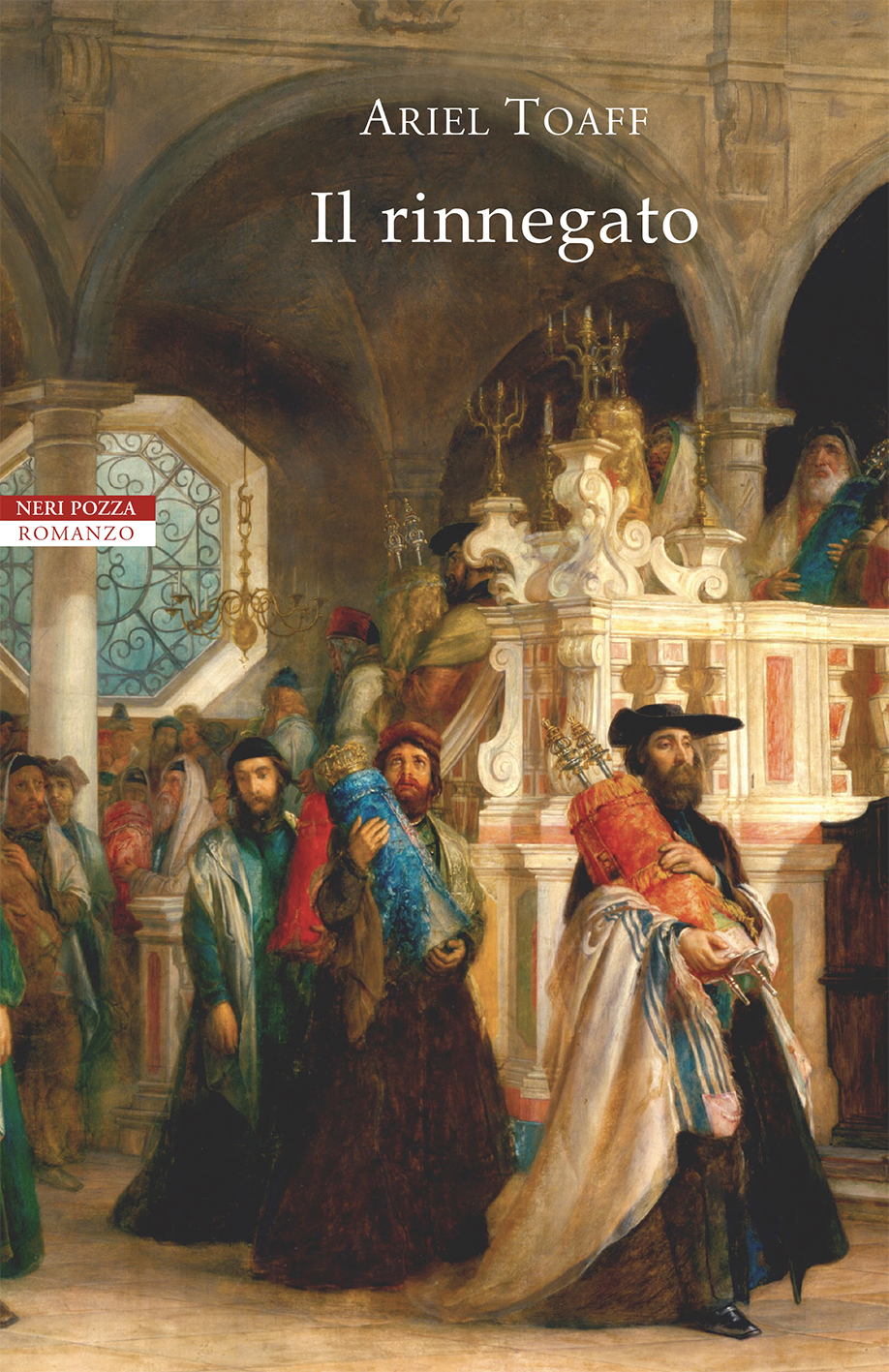ARIEL TOAFF, Il Rinnegato
Come un artista che sa padroneggiare perfettamente, e con sapienza, la materia che cesella, così è Ariel Toaff nel suo primo “romanzo”, Il Rinnegato, che forse proprio romanzo non è – e nemmeno “giallo”. Il Rinnegato è qualcosa di diverso o, meglio, di più. Più della somma di questi due termini, con i quali si è tentato di definirlo e inquadrarlo, e sicuramente più della somma degli elementi della storia – realmente accaduta – che egli narra.
Il racconto è piuttosto un vortice di parole: primi piani, giochi di luce simbolica, giochi di ombre misteriose e allusive, storie di luoghi antichi, narrazione di vicende dense e drammatiche, volti drammatici e amorosi. E, fra loro, parole, fiumi di parole, e un diario paterno – imprevisto e non risolto.
Si tratta, anche, di un grande affresco corale e quasi “musicale” – armonico e armonioso, nelle sue difficoltà e amarezze – che si snoda tra la Palestina ottomana e la Comunità ebraica sefardita di Livorno del XIX secolo, tra sephirot ed eretiche interpretazioni trinitarie del seder di Pesach, mentre l’Europa occidentale si lacera e si modifica per sempre, tra la Rivoluzione francese e la Prima Rivoluzione industriale inglese.
E i protagonisti, grazie alla maestria di Ariel Toaff, scivolano fra le parole e attraverso i fatti della storia di quel periodo, contrastato e ricco, con una seduzione travolgente, che passa per il dialogo sapiente e accattivante. Eleganti, saggi, intellettuali, sensuali, ma anche tristi, diseredati, malinconici e terribilmente “umani”.
E mentre le parole e i fatti si rincorrono, le luci vengono accese o spente intorno ai volti dei protagonisti, i fondali invadono la storia e isolano i volti e la narrazione – e a volte il tutto, in questo racconto, si trasforma: non più parola, non ancora, quasi del tutto, immagine.
In alcuni passi, il racconto si trasforma – anche – in una sorta di partitura musicale. L’orchestra suona, e Ariel Toaff (come un direttore d’orchestra o un regista) coordina strumentisti, strumenti e note, e con la sua bacchetta impartisce il ritmo. E il racconto diviene musica per le nostre orecchie perché l’autore aleggia nell’aria e padroneggia gli eventi con precisione impeccabile ma, anche, crea.
E dà così vita a un racconto, non più solo segno, non ancora del tutto musica, ed entrambi contemporaneamente.
Solo un rabbino dello spessore e della preparazione di Ariel Toaff poteva avere il coraggio di presentare e raccontare la storia (vera) di David Ajash, il rabbino cabalista italiano di origine algerina, trovato morto – non si sa se fu un suicidio o un omicidio – sotto un ulivo, alla periferia di Nablus, una mattina di novembre del 1840.
Solo un rabbino come Ariel Toaff poteva avere la forza per riuscire a padroneggiare l’insostenibile leggerezza della parola e narrare di interni e di strade, delle tante strade che conducono alla morte misteriosa e irrisolta di David Ajash, senza iperbole, senza gioco degli equivoci, senza scene madri – e i dialoghi (immaginati) si mescolano alla storia e ai dettagli reali, mentre il tutto sembra sospeso tra quello che viene vissuto e quello che viene immaginato.
Tutto è raccontato per quadri, mentre alla storia di David Ajash se ne alternano altre che, alla sua, fanno da sfondo e da quinta teatrale.
Le voci narranti si alternano: Abram Crespo, amico fedele e affezionato di David Ajash, consegna al figlio Moisè, dopo il funerale del padre, un insieme di fogli sparsi, ingialliti e consumati dal tempo, in cui David Ajash ha scritto di sé e della sua vita “dissoluta” di rabbino “libertino”sullo sfondo di una società in forte cambiamento – tra dibattiti cabalistici, ortodossia religiosa, massoneria e logge massoniche, alleanze difficili, cambi rituali di nome per sviare un destino avverso, e una conversione improbabile.
Alla voce di Abram Crespo, che apre e conclude il libro, si alterna quella di Moisè, che legge il memoriale del padre, e quella di David, che si narra, nel memoriale, in tutta la sua immensa umanità.
E Ariel Toaff usa le sue parole come un musicista virtuoso, per dare voce a tutti i personaggi, seduce e accompagna nelle riflessioni e nel racconto: David, la cui voce è un’orchestra intera, riesce così a sedurre il lettore.
E poi esterni, interni, strade, gente, libri, tanti libri, stampe ebraiche, poltrone, letti, tazze di tè alla menta, brodi caldi, dolcetti, biscotti, frittelle, golose trasgressioni alla casherut, talismani, amuleti, simboli massonici, carezze, lacrime, corridoi, stanze, addii, ritorni e slittamenti progressivi dell’amore, con i personaggi femminili, tutti bellissimi, anche se l’autore tiene un “profilo basso”, non ostentato, a volte ironico ma sempre emozionante, senza mai forzare la linea sensuale, senza enfatizzare.
C’è il sesso, certo, la piccola morte che permette al protagonista di dimenticare quella grande, ma c’è anche la madre, Perla – che sembra una preziosa filigrana d’argento; ci sono Gheula, Adina e Hannah, le tre ragazzine devote che si occupano di Abram e della sua casa; c’è la moglie Sultana, sposata per dovere e senza particolare convinzione, e poi abbandonata; c’è Giusi, l’amante – che appare come un corallo lucido e incastonato in una collana, che lo ossessiona con la sua presenza e con la vertigine dell’assenza. E infine la vedova Danon, gentile e sottile, che lo accompagnerà nell’ultimo periodo della sua esistenza e che sa preparare una mussaka indimenticabile.
Tutte parlano attraverso la voce dell’autore – che contemporaneamente è in ascolto assoluto e fa da tramite fra David e suo figlio Moisè che ne legge il memoriale.
Ma è meglio non cadere nel facile tranello emotivo/intellettuale di volere cercare, a tutti i costi, assonanze autobiografiche con l’Autore, esplorando oltre il necessario, ad esempio, il rapporto padre-figlio o cedendo a riflessioni, non necessariamente sempre autobiografiche, sulle perplessità, i dubbi e il mondo interiore del rabbino Ajash. Si rischierebbe di avere, di questo racconto, che è di una bellezza stupefacente e imperdibile, una visione distorta, preconcetta e in sostanza un po’ sfalsata.
Perché Ariel Toaff è tutto questo, ma anche molto di più, e non resta che prendere o lasciare. Negli scrittori, la sostanza autobiografica è in qualche modo sempre latente, ed è inevitabile, ma, negli scrittori bravi, come in Ariel Toaff, che è uno Scrittore completo, essa diviene materia e strumento, artificio e alchimia, insieme alla ricerca storica, per ridare vita e donare luce alla figura del rabbino Ajash.
Questo raffinato processo alchemico, binario, offre un sorprendente insieme di sopra, sotto, prima, dopo, dentro, con voci ebbre, tenere, furiose, intime, letterarie, pie, religiose, cabalistiche, massoniche, senza soluzioni di continuità, con magistrali momenti storici, temporali e geografici, dentro i ricordi ma anche dentro i sogni o le fantasie.
Il testo della lapide che David Ajash ha fatto preparare per la propria sepoltura recita così:
Qui giace David Ajash
(1788-1840)
che ha appreso il segreto
di come trasformare
l’apparenza in realtà.
Che la sua anima sia legata
al vincolo della vita.
Eccolo, è tutto qui il segreto, è qui la chiave dell’interpretazione di tutta la vita di David Ajash, di cui nemmeno lui è consapevole: infamie, calunnie, tradimenti, minacce, sbagli, sensi di colpa, abbandoni, amori giusti e amori sbagliati, accettazione, non-accettazione, tutto trova risposta in quelle tre righe ermetiche – che ha appreso il segreto/di come trasformare/l’apparenza in realtà – che si annodano strettamente alle prime righe del Prologo, recitato da Abram Crespo:
… Certi uomini ad aggiustarli si fa peccato. Quando approdano in terra straniera, gli anni e le sventure li hanno già segnati nel profondo. Dopo aver a lungo navigato in acque rischiose, hanno trovato in se stessi il peggior nemico, ma scelgono comunque un nuovo posto in cui provare a rinascere, o quantomeno a vivere il tempo che gli resta. Tentare di salvarli, di correggere in extremis il loro cammino, è del tutto inutile: ci hanno provato già, a più riprese, conoscendo altrettanti fallimenti. Solo il passato può mettere un punto alle loro vicende, tornando un giorno a chiedere conto dei loro errori…
David Ajash, che ama il Signore e la Religione dei Padri e la Kabbalah molto più di quanto sia disposto o voglia ammettere, ama talmente il Signore che, quasi inconsciamente, per ritenersi degno di amarlo, arriva a convincersi che si debba precipitare in fondo alla perdizione per accedere alle più alte sfere della conoscenza, anche rinnegando, per poi ritornare sui suoi passi, sempre divorato dalla sua libertà di pensiero e dal suo desiderio di scelta assoluta e senza calcoli.
La dottrina scandalosa di Sabbatai Zevi e del suo seguace Jacob Frank spingeva, all’epoca, molti ebrei benestanti ad allontanarsi dalla religione e, in modo assai contorto, … permetteva ad altri ebrei di restare in seno all’ebraismo e, addirittura, di sublimarlo. … L’opinione peccaminosa di Jacob Frank (Il Messia doveva salvare il mondo con il peccato; Ogni cosa deve essere distrutta perché il buon Dio mostri se stesso) spingeva i suoi seguaci ad abbandonare l’ortodossia, esortandoli a tradire le loro origini e a divenire incarnazione della vergogna. Solo in quel modo, distruggendo per poi ricostruire, si sarebbe potuto restituire al popolo ebreo la purezza che aveva irrimediabilmente perduto.
Ma David Ajash ride della ridicola voce della sua adesione al franchismo: io volevo solo avvicinarmi a me stesso.
Tuttavia il Signore, che è Grande e Misericordioso, ha visto, di David, anche i gesti da lui fatti in maniera spontanea e naturale, mosso solo da un istinto di Giustizia; ha visto che si è opposto a sordidi soprusi e laide vessazioni nei confronti dei deboli e degli inermi; ha visto che si è privato dei propri beni e dei propri averi per aiutare i bisognosi; ha visto che ha sempre avuto una parola benevola e un gesto gentile nei confronti degli umili; e lo accoglie e lo perdona, e gli perdona la sua vita dissoluta e spregiudicata, il suo andare e venire tra giudaismo e cristianesimo, il suo comportamento “da rinnegato”.
E, alla fine, nel giorno del suo “secondo” funerale, sarà proprio Vidal lo yemenita, l’umile, umilissimo Vidal, a completare il rito della “seconda” sepoltura – sotto uno spaventoso diluvio – scavando ai piedi della lapide, tra pioggia e fango, per seppellirvi un cilindro di coccio contenente quel misterioso sigillo che, come un jinn, ha accompagnato tutta la vita di David Ajash e di suo padre.
Un sigillo realizzato da chi ha carpito il mistero di Lilit, lo sa combattere e annullare, rendendo vane le trame dei demoni e mettendoli in fuga… Un sigillo da custodire con cura e precauzione… che deve essere usato al momento giusto e nelle condizioni opportune. Soprattutto ha da rimanere in mano di chi si mostra degno di poterlo conservare e crede nella profonda scienza della Cabala possedendo le chiavi per sondare i suoi ineffabili arcani… I furfanti che hanno provato a impossessarsene con ogni mezzo, con la violenza o con l’inganno, senza successo, sono stati ebrei e cristiani, ladri, assassini e malfattori, ecclesiastici, falsi massoni e finti rabbini…
Vidal lo yemenita, strumento del Signore, con quel gesto consegna finalmente David Ajash alla Pace e, forse, a un nuovo cammino.
BdM, 30 aprile 2022